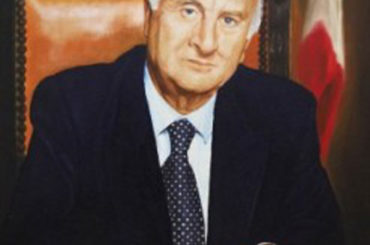Lezione della Scuola di Liberalismo di Roma – 19 dicembre 1997
Il liberalismo nel mondo islamico, nel mondo arabo in particolare, ha una storia molto travagliata e molto difficile, in un certo senso è una storia di sconfitte. Se si guarda alla storia della cultura del pensiero e della filosofia araba, anche se può sembrare per molti versi sorprendente, in realtà il liberalismo sarebbe potuto nascere, poiché alcune delle premesse di massima erano presenti in quel mondo, addirittura nel XIII secolo, quindi con molti secoli di anticipo rispetto all’Europa.
Già nel XIII secolo infatti nasce un vasto e molto importante movimento di pensiero che alcuni definiscono addirittura preilluministico e di cui conosciamo, dai manuali scolastici, alcuni nomi, Ibn al Valid, Averroè. Un pensatore arabo come Al Faradi già nel XIII secolo parlava di rispetto dei diritti dell’individuo nelle relazioni musulmane; sempre in un pensiero di Al Faradi c’era già una concezione quasi compiuta della tolleranza, e cioè la concezione della tolleranza e del rispetto delle altrui fedi religiose, delle altrui convinzioni. Inoltre, riflessi di queste concezioni arabe sono testimoniate nella letteratura occidentale. Se qualcuno di voi ricorda il Decameron di Boccaccio ricorda la parabola delle tre monete. Nessuno dei tre figli che avevano ereditato le monete sapeva qual era quella di valore, quindi tutte e tre erano preziose. Dunque tutti e tre, in qualche modo, erano portatori di una verità mentre nessuno dei tre poteva negare che gli altri sostenessero di aver la moneta originale. Questa era una parabola sulle tre religioni, cioè l’islam, l’ebraismo e il cristianesimo. Tutte e tre hanno un messaggio divino, o tutte e tre ritengono di averlo, però non è possibile per nessuno dire quale delle tre è quella vera; tutte e tre hanno eguale diritto di praticare i propri culti nello stesso territorio. Difatti la tolleranza veniva poi praticata in molti Stati islamici e arabi e per molti secoli la condizione degli ebrei fu migliore in Turchia o in Tunisia e nel Nordafrica in generale che non nell’Europa cristiana.
Nelle sue Memorie Casanova racconta di essere finito, nelle sue tante peregrinazioni, ad Istanbul e di aver conosciuto un europeo convertitosi per convenienza all’islam, ma che di fatto non praticava nessuno dei precetti religiosi. Allora Casanova parlando con il muftie si rende conto che egli conosce i comportamenti di questo ricco francese convertito e gli domanda come mai non interveniva. La risposta fu: “Perché devo intervenire? Ci penserà Allah quando arriverà al suo cospetto. Noi non possiamo imporre con la forza i precetti dell’islam”.
Era già una concezione assolutamente “laica” dei rapporti tra Stato e religione, tra politica e religione, tra governo e funzione religiosa, ed era una concezione che era in vigore nel Settecento in Turchia, centro di un vasto impero che arrivava fino al Marocco, fino all’Oceano Atlantico.
Perché in realtà da questi fermenti, da questi spunti non è nato mai un liberalismo compiuto nel mondo islamico? E anzi ha fatto sempre fatica ad affermarsi una volta che vi è poi arrivato dall’Europa? Dare una risposta è difficile, poiché le ragioni sono assai complicate, e forse nessuno le ha.
C’è chi dice che la concezione islamica del Corano è incompatibile in realtà con il liberalismo, però spunti di tolleranza o di visione, non dico di tipo liberale, ma di visione non integralista dell’islam si trovano già nelle parole di Maometto quando dice che Allah, cioè l’Essere Supremo, aveva parlato agli Ebrei e aveva dato loro l’Antico Testamento, poi aveva parlato ai Cristiani e aveva dato loro il Nuovo Testamento, e parlava agli Arabi attraverso di lui.
Questo significa che nella visione di Maometto cristianesimo ed ebraismo erano parola divina, quindi andavano considerati come parte della Verità, e comunque non andavano perseguitati. Infatti la comunità ebraica viveva una vita tranquilla e prosperava nella Medina di Maometto, dove la prima comunità islamica organizzata si affermò.
Venendo ai tempi moderni, nei primi anni del XX secolo, possiamo individuare la forma di un pensiero liberale organizzato e cosciente, quando il mondo arabo, per così dire, ha un primo risveglio. Una volta avvenuta la colonizzazione europea di tutti i Paesi arabo-islamici, in pratica dalla Persia fino al Marocco, nell’Africa Nera e in Medio ed Estremo Oriente, nasce per diffusione dalla metropoli (Londra o Parigi) il pensiero liberale, che alcuni intellettuali arabi studiano e propongono come soluzione al problema della risposta nazionale dei singoli popoli e Paesi islamici.
Un primo esempio l’abbiamo con Sad Zagglul ???, un avvocato che nei primi anni del secolo formò il partito Wafd egiziano; l’Egitto in quel periodo aveva un status giuridico un po’ complesso, era un protettorato britannico e di fatto non era indipendente, anche se giuridicamente sul piano del diritto internazionale pareva esserlo. Il primo Wafd aveva una concezione prettamente ottocentesca, ossia di tipo elitistico, ma era già un movimento di orientamento liberale. Chiedeva tutta una serie di riforme, una Camera e un Senato, una Costituzione, una Carta dei diritti dell’uomo, la fine dei vincoli che opprimevano l’economia egiziana, sottomessa agli interessi dell’impero britannico. Insomma, una serie di istanze che possiamo definire liberali.
Questo partito ebbe un’evoluzione verso forme di populismo sempre più estremistico e nazionalistico; uno dei problemi del primo liberalismo egiziano (non solo in Egitto ma in tutto il mondo arabo) è che ha accompagnato un risveglio nazionale simile a quello del primo Novecento europeo.
Il Wafd poneva l’accento sempre di più sul nazionalismo piuttosto che sul liberalismo ed il rispetto dei diritti degli individui., più su una concezione araba della comunità piuttosto che su una concezione europea liberale degli individui, del rispetto degli individui.
Tant’è che nel 1922 un gruppo di esponenti di questo partito uscirono dal Wafd per formare il partito dei costituzionalisti liberali, in concorrenza con il Wafd, che poneva come punto fondamentale del proprio programma la promulgazione di una Carta dei diritti dell’uomo e un complesso di dottrine molto simili ai punti programmatici dei liberali inglesi dell’epoca. Pur vivendo una lunga stagione, il partito va avanti con alterne vicende fino alla rivoluzione del 1954, quella che portò al potere Nasser. Vive però una vita rigidamente minoritaria e in realtà non fa nessuna presa sulla società egiziana e sul sentire della gente egiziana che invece si rivolge al Wafd e ne fa il proprio punto di riferimento. Il Wafd ogni volta che ci sono pubbliche elezioni in egitto le vincerà con larghissima maggioranza.
La rivoluzione del 1954 per certi versi apre nuove speranze liberali, infatti le prime prese di posizione dei militari che cacciano il re sono di apertura a certi punti programmatici liberali, cioè il pluripartitismo e il rispetto dei partiti organizzati. Poi la storia egiziana ebbe tutto un altro sviluppo, che con Nasser ebbe anche dei momenti molto importanti e significativi sul piano interno e internazionale, ma che comunque non possiamo definire liberale.
Sempre nei primi anni del nostro secolo l’Algeria, colonia francese di vecchia data, e quindi largamente influenzata dalle concezioni e dalla cultura francesi, vede l’affermarsi di un movimento il cui leader era il dottor Ferat Abbas, un farmacista, figura di rilievo nel mondo arabo, non solo dispensatore di medicine, ma anche medico, intellettuale e punto di riferimento dei salotti culturali.
Ferat Abbas scrive il manifesto del popolo algerino, di impronta liberale ottenendo adesioni straordinarie da parte di moltissimi esponenti della società algerina ed è guardato con occhio benevolo perfino da esponenti illuminati delle autorità francesi. Esisteva infatti una dialettica interna tra le autorità francesi, ossia tra gli aperturisti propensi a una transazione morbida verso l’indipendenza futura dell’Algeria e coloro che invece erano convinti che l’Algeria sarebbe stata per sempre francese.
Il manifesto del popolo algerino ebbe molti favori, e nacque anche un partito organizzato, il Partito del manifesto che per molti anni ebbe un programma squisitamente liberale, con una caratterizzazione ottocentesca. Però, superata la prima guerra mondiale, e soprattutto superata la seconda, anche il Partito del manifesto ebbe un’evoluzione simile a quella del Wafd egiziano, cioè mise l’accento più sul nazionalismo che non sul liberalismo, più sulle istanze comunitarie che non sulle istanze liberali. Inoltre successivamente vi furono anche delle vaste influenze socialiste a comporre un cocktail che fece sì che il manifesto ebbe larghissimi consensi.
Ma come nel Wafd c’era al suo interno tutto e il contrario di tutto, e le contraddizioni non ressero quando poi ci fu la rivoluzione algerina e la guerra e la vittoria e l’indipendenza nazionale, e il Fronte di Liberazione nazionale algerino. I militari imposero una direzione ben precisa al nuovo Stato.
L’ultimo esempio che vi voglio citare fra i più significativi è l’esempio marocchino. Qui uno scienziato, un fisico che aveva studiato in Francia che si era fatto anche una certa fama, Allal Elfassì fondò un movimento che si chiamava Istiqlal. Il movimento alle sue origini ebbe il suo programma mutuato dal programma dei radicali francesi, che aveva anche delle punte liberal-democratiche rispetto al liberalismo elitario degli altri movimenti.
In questo Paese l’evoluzione fu inversa, invece di radicalizzarsi progressivamente, invece di rimanere sempre di più un partito accesamente nazionalista e di rottura rispetto agli equilibri sociali della società araba, l’Istiqlal in qualche modo annegò nella mediazione propugnando una via morbida al risveglio nazionale. Propugnando un’intesa con il sultano, ebbe una serie di passaggi in cui il programma diveniva sempre più di mediazione finché si era sempre più annacquato.
La società marocchina aveva un’antichissima tradizione di tolleranza; molte città per lungo tempo furono una sorta di porto franco dove si incontravano comunità ebraiche, greche ortodosse, cristiane, oltre naturalmente alle islamiche. Quindi era più facile che una certa visione della tolleranza del rispetto delle fedi, diciamo certi prerequisiti liberali in Marocco si affermassero, il problema è che per lunghi anni si è rimasti fermi ai prerequisiti, oltre i quali non si andò, e non si affermò una concezione più laica del liberalismo.
Il panorama del mondo arabo ed islamico in generale appare inquietante al mondo occidentale; i massacri algerini, il caso Rushdie, i Taleban afghani, il Sudan dove continuano i massacri, tutte queste vicende suscitano reazioni di raccapriccio. Il fatto che certe cose succedano anche in Egitto, dove ci sono stati recentemente attentati contro turisti, fa crescere ancora di più la preoccupazione e fa sì che si creda che ci sia un dilagare di integralismo di fanatismo e di intolleranza in tutto il mondo arabo e ancora di più in tutto il mondo islamico, che ricordiamoci va dall’Indonesia fino all’Oceano Atlantico e comprende quasi la metà del continente africano.
Però ci sono anche dei segnali che vanno in direzione opposta. In realtà la società algerina è una società che è aggredita da certi fenomeni che non sono propri della cultura islamica in quanto tale, non sono propri neanche della religione islamica in quanto tale. E’ una società che sta cercando in tutti i modi possibili e immaginabili di difendersi da questa aggressione. Ed è una società in cui la fede nell’Islam spesso va insieme alla fede per la libertà, nel rispetto dei diritti dell’uomo e della donna.